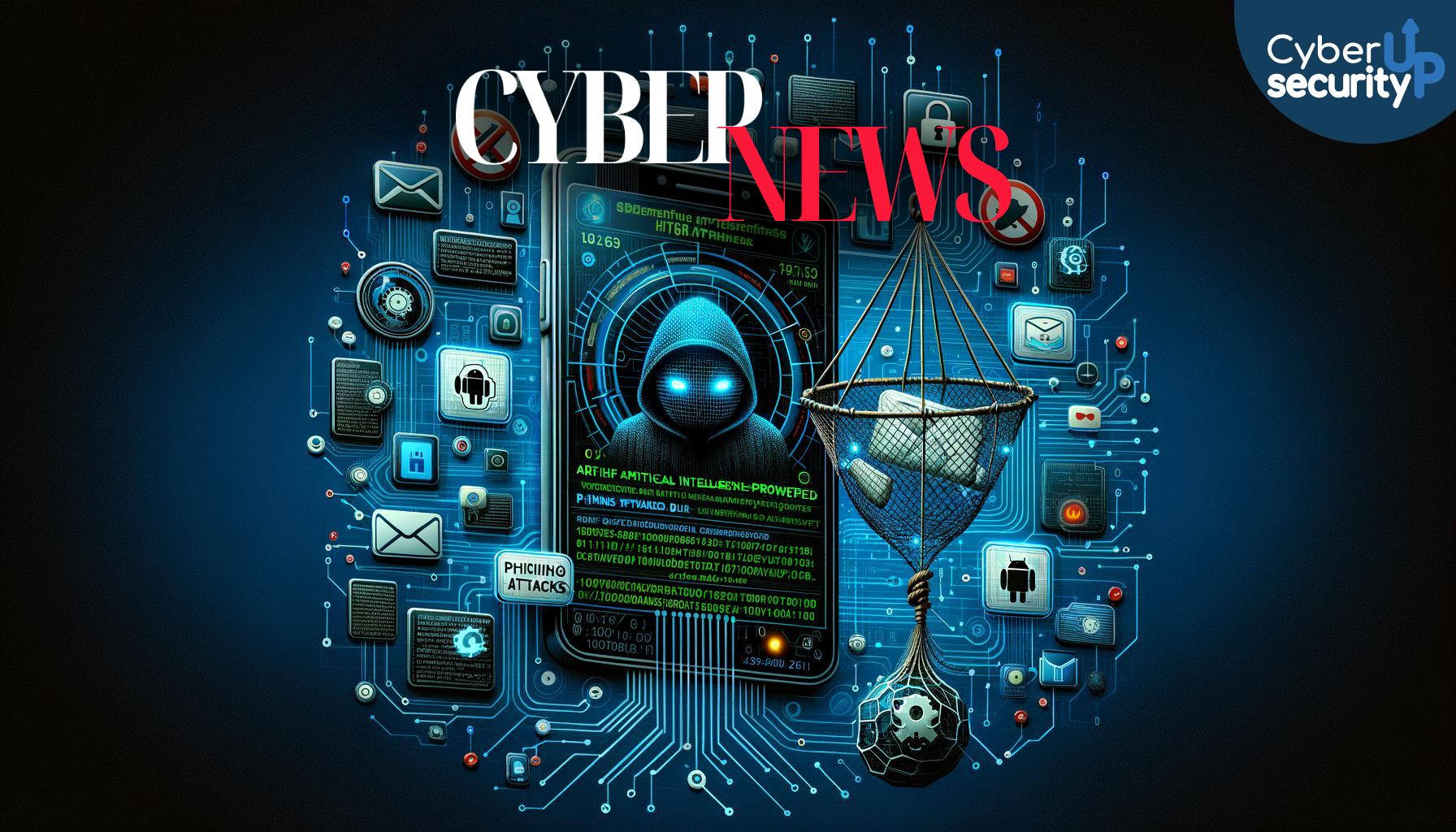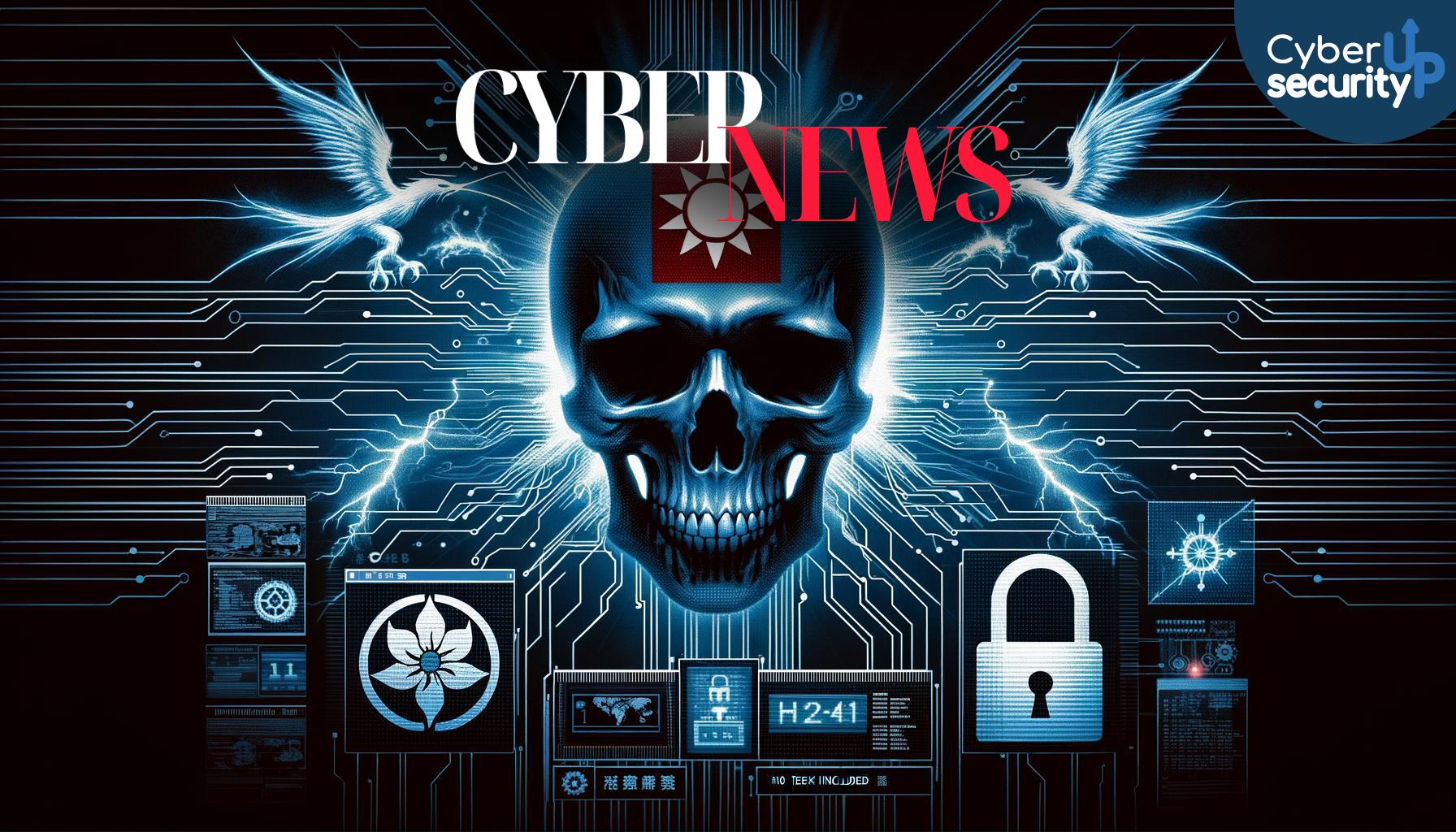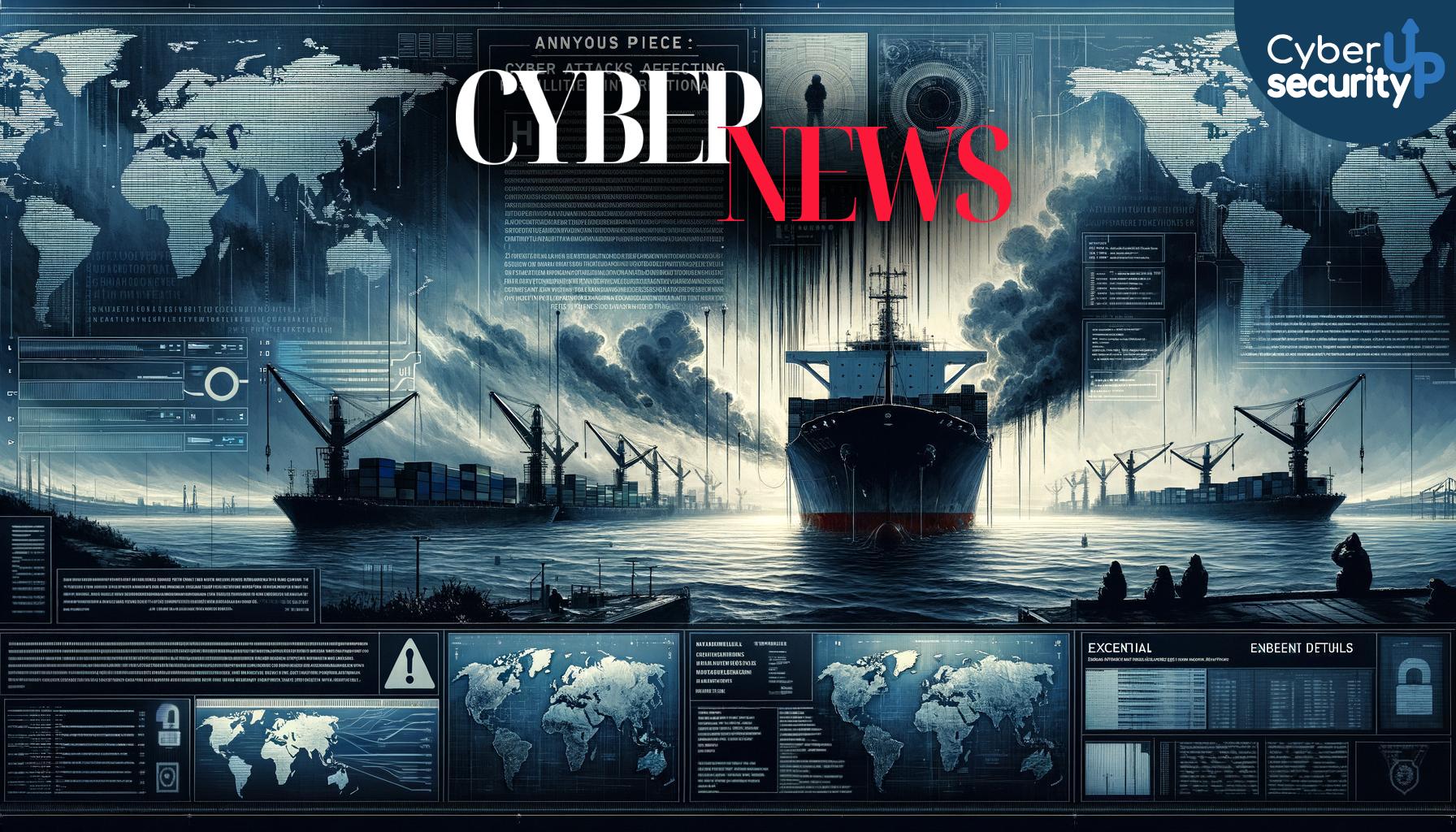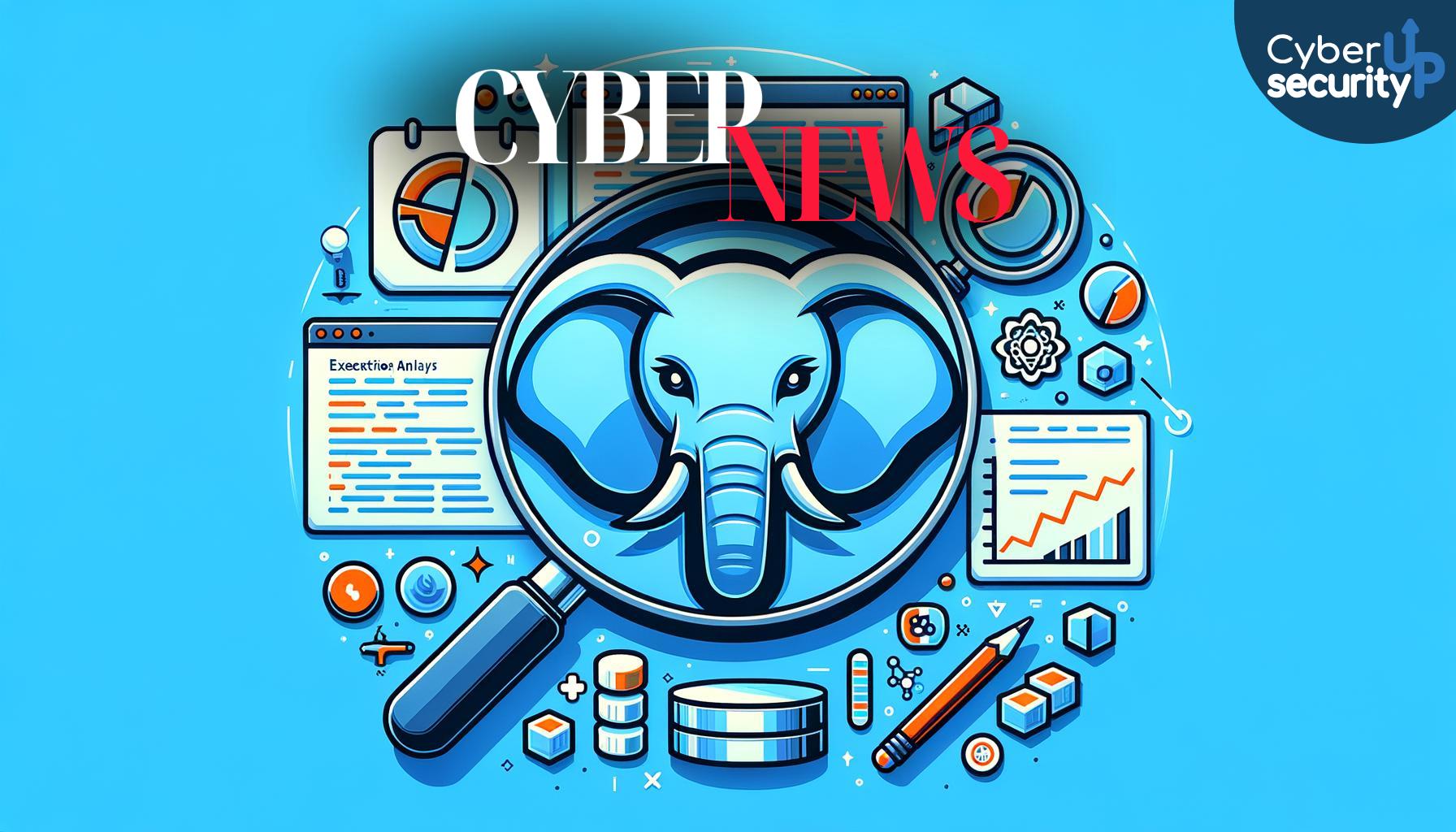Le organizzazioni in Kazakistan sono state recentemente bersagliate da un gruppo di attività di minaccia noto come Bloody Wolf, che impiega un malware chiamato STRRAT (anche conosciuto come Strigoi Master). Questo malware, venduto per soli 80 dollari in risorse sotterranee, permette agli aggressori di prendere il controllo dei computer aziendali e di sottrarre dati riservati.
Un gruppo di cybercriminali di lingua spagnola noto come GXC Team è stato osservato mentre combinava kit di phishing con applicazioni Android dannose, portando le offerte di malware-as-a-service (MaaS) a un nuovo livello. La società di cybersecurity di Singapore Group-IB, che monitora questo attore da gennaio 2023, ha descritto la soluzione come una "piattaforma di phishing-as-a-service alimentata dall'IA" capace di prendere di mira utenti di più di 36 banche spagnole, enti governativi e 30 istituzioni in tutto il mondo.
Le aziende di cybersecurity stanno lanciando l'allarme riguardo un aumento nell'abuso del servizio gratuito TryCloudflare di Cloudflare per la distribuzione di malware. Attività documentate da eSentire e Proofpoint rivelano che i cybercriminali stanno sfruttando TryCloudflare per creare tunnel a velocità limitata, che fungono da condotti per trasmettere traffico da server controllati dagli attaccanti a macchine locali attraverso l'infrastruttura di Cloudflare.
Un istituto di ricerca taiwanese affiliato al governo, specializzato in informatica e tecnologie correlate, è stato recentemente compromesso da attori di minacce statali con legami con la Cina. Secondo le nuove scoperte di Cisco Talos, l'attacco è stato attribuito con media fiducia a un gruppo di hacker prolifici noto come APT41.
Gli esperti di cybersecurity stanno lanciando un allarme riguardo a una nuova campagna di phishing che mira agli utenti di Microsoft OneDrive con l'intento di eseguire uno script PowerShell dannoso. Questi attacchi, che sfruttano tecniche di ingegneria sociale, sono progettati per ingannare gli utenti inducendoli a eseguire comandi che compromettono i loro sistemi.
Attacchi Informatici SideWinder: Minaccia Globale per Strutture Marittime di Asia e Mediterraneo
- News
- Visite: 4840
Il gruppo di cyber spionaggio noto come SideWinder è stato recentemente collegato a una nuova campagna di attacchi informatici che prende di mira strutture marittime situate nell'Oceano Indiano e nel Mar Mediterraneo. Il team di Ricerca e Intelligence di BlackBerry ha scoperto questa attività, rivelando che gli obiettivi includono nazioni come Pakistan, Egitto, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nepal e Maldive.
MISP è una piattaforma open-source per l'intelligence sulle minacce e la condivisione, ideata per raccogliere, archiviare, distribuire e condividere indicatori di cybersecurity e minacce legate all'analisi degli incidenti e del malware. MISP è progettata da e per i professionisti della cybersecurity, ICT e malware reversers per supportare le loro operazioni quotidiane condividendo informazioni strutturate in modo efficiente.
DigiCert, una delle principali autorità di certificazione (CA), ha annunciato che revocherà oltre 83.000 certificati SSL/TLS entro 24 ore a causa di un errore nel processo di convalida del dominio (DCV). Questa decisione è stata presa dopo che la società ha scoperto un problema nel modo in cui verificava se un certificato digitale era stato rilasciato al legittimo proprietario di un dominio.
Un gruppo di cyber spionaggio poco conosciuto, denominato XDSpy, ha recentemente preso di mira aziende in Russia e Moldova attraverso una campagna di phishing. Secondo la società di cybersecurity F.A.C.C.T., la catena di infezioni porta all'installazione di un malware chiamato DSDownloader, come osservato questo mese.
Statsviaexplainanalyze è uno strumento rivoluzionario che semplifica l'analisi dei piani di esecuzione in PostgreSQL, raccogliendo le statistiche sottostanti in un unico report HTML. Questo strumento automatizza la raccolta di statistiche sugli oggetti di database come tabelle, indici o colonne coinvolti nel piano di esecuzione, rendendo più facile l'analisi e la condivisione dei risultati tra i membri del team o su forum esterni.
- Docker sotto attacco: Vulnerabilità critica CVE-2024-41110 mette a rischio milioni di server!
- Truffa Invisibile su Magento: Skimmer di Carte di Credito Nascosto nei File di Swap
- Malware Android in Aumento: Rubati OTP tramite Telegram in 113 Paesi
- Allarme CISA: Scoperte Due Gravi Vulnerabilità che Minacciano la Sicurezza Globale
Pagina 144 di 188
Cyber pillole più lette
- Pillole di Pentration Testing: Un altro punto di vista sulle vulnerabilità: CWE
- Pillole di analisi forense: I file Thumbs.db
- APC Injection
- Pillole di Ethical hacking: Shodan, il motore di ricerca più pericoloso al mondo
- Fuzzy Hashing
- Come un malware può Killare un antivirus.
- Come #Emotet da trojan bancario è diventato la più grande botnet in attività
- DLL Injection in linguaggio C
Articoli più letti
- Geolocalizzazione, tutto ciò che devi sapere: pericoli e sfide
- Ancora app fraudolente, ancora su Google Play Store: Android nell’occhio del ciclone
- Conti svuotati dopo aver ricevuto un SMS: ecco il Phishing che danneggia i proprietari di PostePay e PostePay Evolution
- Il Penetration testing, cos'è e come funziona
- Un malware attacca gli sportelli Bancomat e gli fa sputare banconote all’impazzata!