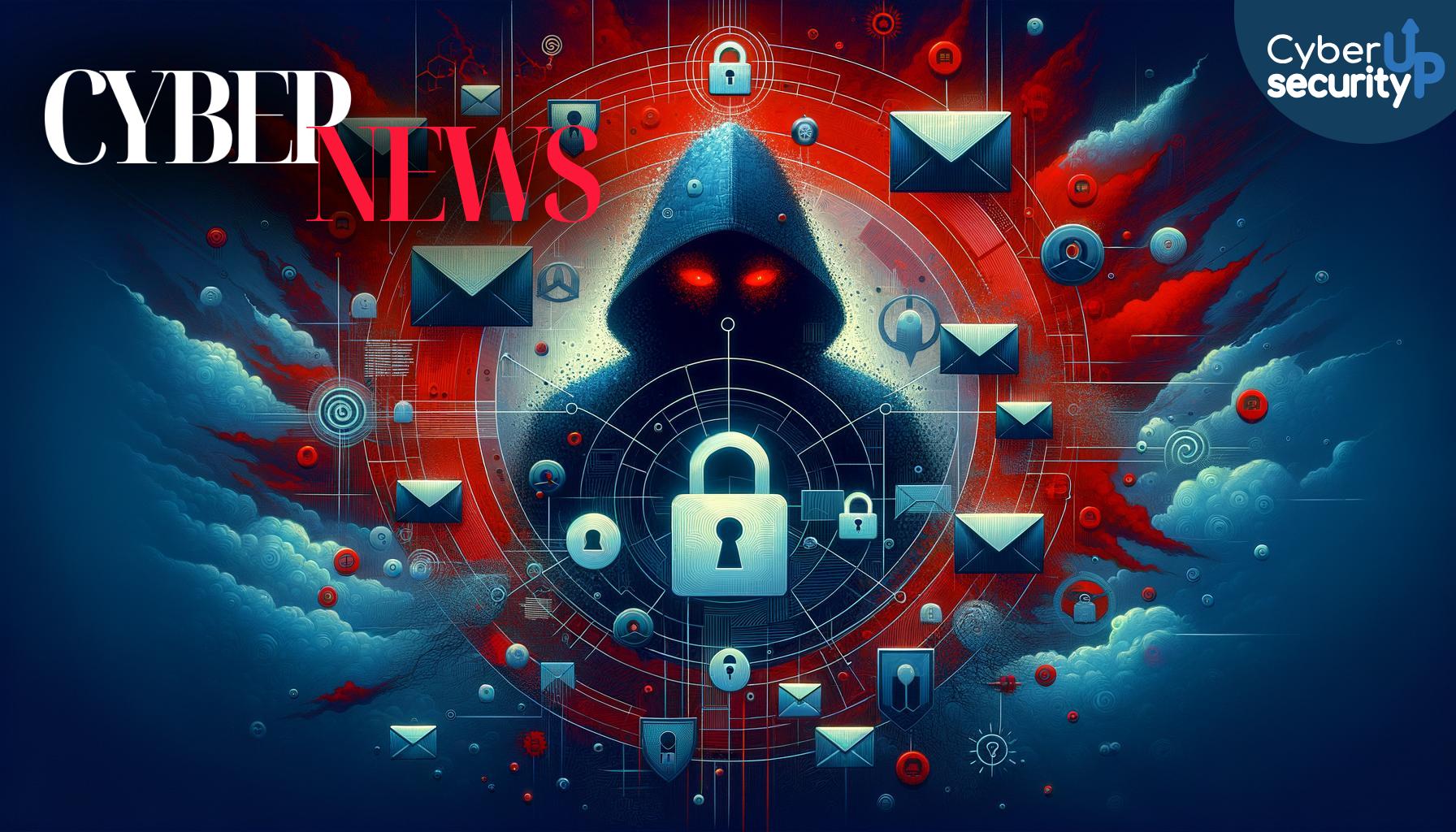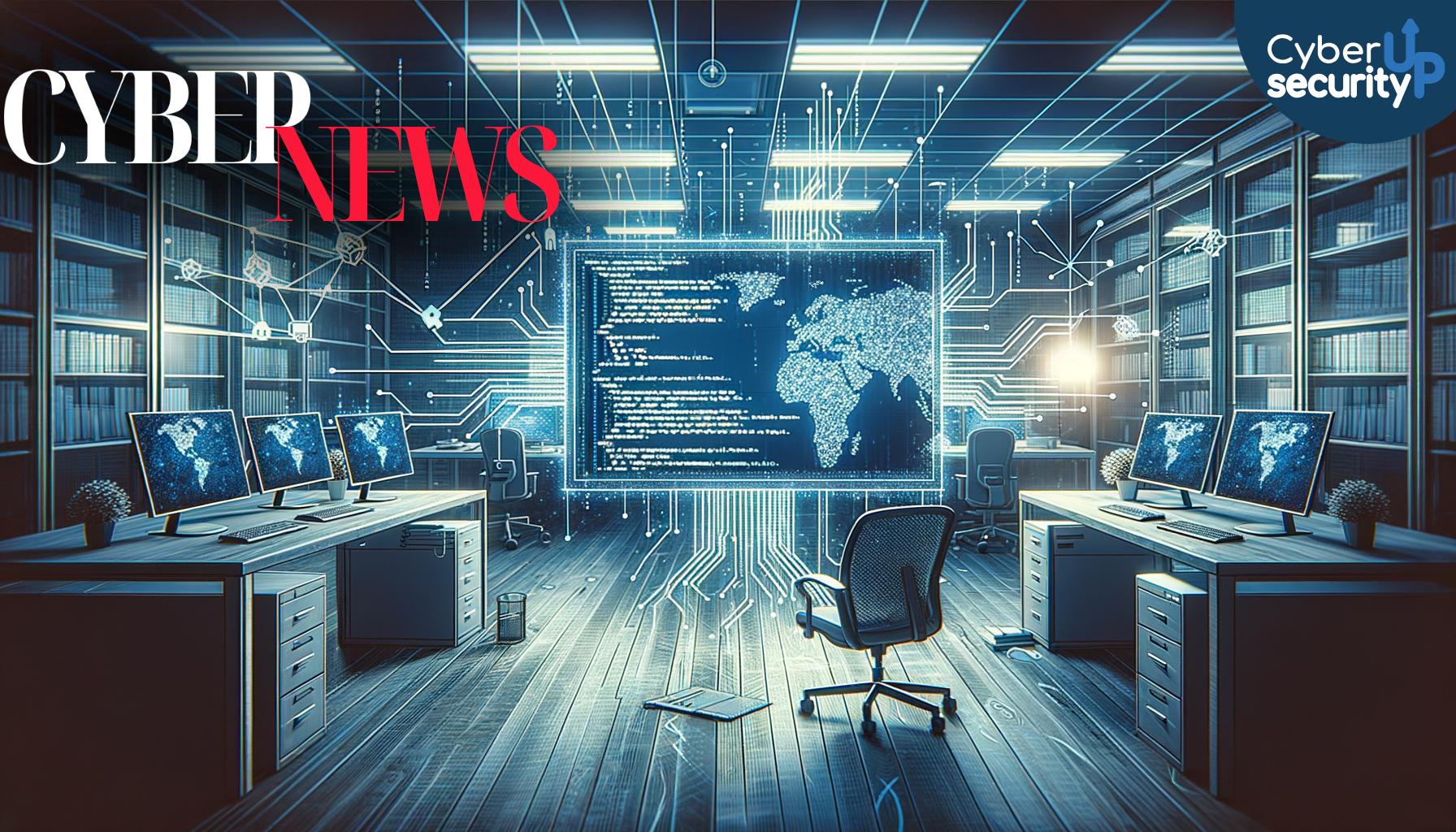Vulnerabilità Catastrofiche in Roundcube: Rubati Email e Password con un Semplice Click
- News
- Visite: 5532
Le recenti vulnerabilità scoperte nel software di webmail Roundcube hanno messo in allarme la comunità della cybersecurity. Gli esperti hanno rivelato che queste falle possono essere sfruttate per eseguire JavaScript malevolo nel browser della vittima, permettendo ai malintenzionati di rubare informazioni sensibili dall'account della vittima, come email e password.
LianSpy è un nuovo spyware Android in grado di eludere la rilevazione sfruttando Yandex Cloud. Gli utenti in Russia sono stati presi di mira da questo spyware dal 2021.
Un attore sconosciuto ha sfruttato una configurazione errata nel sistema di routing delle email di Proofpoint per inviare milioni di email di phishing falsificate spacciandosi per aziende note come Best Buy, IBM, Nike e Walt Disney. Questa campagna, denominata EchoSpoofing, è iniziata a gennaio 2024, con il numero di email inviate che ha raggiunto un picco di 14 milioni di email al giorno a giugno, quando Proofpoint ha iniziato a implementare contromisure.
Gli hacker stanno sfruttando notebook Jupyter mal configurati utilizzando uno strumento DDoS originariamente progettato per Minecraft. Secondo i ricercatori di sicurezza informatica, una nuova campagna di attacchi DDoS prende di mira questi notebook esposti a internet.
DEV#POPPER colpisce ancora: Malware multi-piattaforma inganna sviluppatori globali!
- News
- Visite: 5201
Gli attori delle minacce dietro una campagna di malware in corso hanno dimostrato nuove tattiche e un nuovo malware, ampliando il loro raggio d'azione per includere sistemi Windows, Linux e macOS. Il gruppo di attività, denominato DEV#POPPER e collegato alla Corea del Nord, ha preso di mira vittime in Corea del Sud, Nord America, Europa e Medio Oriente.
Negli ultimi mesi, le aziende polacche sono state bersaglio di campagne di phishing che hanno portato all'installazione di diversi malware, tra cui Agent Tesla, Formbook e Remcos RAT. Secondo i ricercatori di cybersecurity, queste campagne hanno preso di mira principalmente le piccole e medie imprese (PMI) in Polonia durante maggio 2024.
Google ha recentemente risolto una grave vulnerabilità di sicurezza che interessava il kernel di Android, sfruttata attivamente in ambienti reali. La vulnerabilità, identificata come CVE-2024-36971, è stata descritta come un caso di esecuzione di codice remoto che colpisce il kernel.
Un attore di minacce noto come Stargazer Goblin ha creato una rete di account GitHub falsi per alimentare un servizio di distribuzione malware (Distribution-as-a-Service, DaaS), ottenendo profitti illeciti per $100,000 nell'ultimo anno. La rete, che comprende oltre 3,000 account sulla piattaforma di hosting di codice, si estende su migliaia di repository utilizzati per condividere link dannosi o malware.
Attacco Hacker Nordcoreano su npm: Pacchetti Malevoli Minacciano i Sistemi Windows
- News
- Visite: 4958
Gli hacker nordcoreani noti come Moonstone Sleet hanno continuato a spingere pacchetti npm malevoli nel registro dei pacchetti JavaScript, con l'intento di infettare i sistemi Windows. Questo evidenzia la natura persistente delle loro campagne.
I ricercatori di sicurezza informatica hanno scoperto un nuovo backdoor per Windows chiamato BITSLOTH, che sfrutta una funzione integrata nota come Background Intelligent Transfer Service (BITS) come meccanismo di comando e controllo (C2). Identificato da Elastic Security Labs il 25 giugno 2024, questo malware è stato usato in un attacco cibernetico mirato al Ministero degli Esteri di un governo sudamericano.
Pagina 143 di 188
Cyber pillole più lette
- Pillole di Pentration Testing: Un altro punto di vista sulle vulnerabilità: CWE
- Pillole di analisi forense: I file Thumbs.db
- APC Injection
- Pillole di Ethical hacking: Shodan, il motore di ricerca più pericoloso al mondo
- Fuzzy Hashing
- Come un malware può Killare un antivirus.
- Come #Emotet da trojan bancario è diventato la più grande botnet in attività
- DLL Injection in linguaggio C
Articoli più letti
- Geolocalizzazione, tutto ciò che devi sapere: pericoli e sfide
- Ancora app fraudolente, ancora su Google Play Store: Android nell’occhio del ciclone
- Conti svuotati dopo aver ricevuto un SMS: ecco il Phishing che danneggia i proprietari di PostePay e PostePay Evolution
- Il Penetration testing, cos'è e come funziona
- Un malware attacca gli sportelli Bancomat e gli fa sputare banconote all’impazzata!